
Mentre lo “spread” impazza e solfeggiano i ridicoli “minuetti” della politica italiana (un passo indietro, l’altro di lato) accompagnati da farisaiche auto-esortazioni ad anteporre il bene comune agli interessi di parte; mentre si ricorre a un governo “tecnico” perché quello politico si avvita su se stesso, incapace di risolvere i problemi della gente; mentre ancora la regina delle super monete assomiglia sempre più agli sviliti “euri” di chi ne vede pochi (quando li vede) e si chiede per quale motivo una imprecisata quantità di “Fratelli d’Italia” disponga di Euro sino alla nausea, ecco che un imprevisto impegno di “viaggio” (a cortissimo raggio, direi) mi relega per una decina di giorni in un ospedale della mia città.
L’evento in se non riveste alcuna importanza per il lettore, abituato a leggere su Mondointasca reportage su paesi vicini e lontani, ben sapendo che ciò che legge è frutto di una diretta visione e di personali esperienze vissute. Per probabile deformazione professionale, anche in questo caso entrano in ballo sia le visioni dirette che le esperienze vissute; entrambe altamente istruttive e, per certi versi, gratificanti. È incredibile come una decina di giorni di assenza forzata dal bailamme quotidiano di una città “semper in trüscia” (sempre in affanno) come Milano, offra alla fine spunti di riflessione davvero consolatori.
La nuova Italia
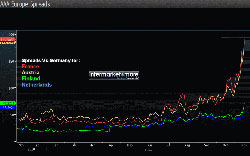
L’internazionalità di chi lavora in questo ospedale (suppongo sia tale anche negli altri) è la nota dominante. Tra infermiere/i, assistenti, personale di supporto e di servizio – un complesso mosaico umano che nell’arco delle lunghe giornate percorre e ripercorre i corridoi, entra infinite volte nelle camere dei degenti e ne esce per infilarsi in quelle attigue – tutti indaffarati, uomini e donne, dandosi di voce quasi a stimolarsi a vicenda (rumori e suoni davvero vivi e vitali), c’è tempo e modo per registrare un accurato “inventario” delle diverse provenienze geografiche di chi svolge qui il proprio lavoro. Lettighiere peruviano, in divisa azzurro scuro, che porta in sala operatoria i degenti e li riconduce in camera ad intervento eseguito; rimboccando la copertina metallica color oro, scambia confidenze con gli “allettati” (sono quelli stesi in un letto!); una volta tornato in Perù, sussurra, si dedicherà a coltivare tabacco.

Poi le infermiere con evidente maggiore anzianità di servizio, anche se giovani. Tutte in bianco, milanesi, che senza “comandare” (tanto il ruolo gerarchico è definito) incitano amichevolmente al lavoro le ultime arrivate; loro sanno cosa fare e le altre imparano. Imparano a infilare aghi per le flebo (magari con qualche “buco” di troppo, ovviamente perché le vene non affiorano sottopelle come dovrebbero, si giustificano); imparano a misurare pressioni, glicemie, temperature corporee con una specie di imbuto infilato nell’orecchio, ossigenazione del sangue con una pinzetta dalla luce rossastra infilata sul dito (quello “medio” non gode di grandi favori): dall’alba a notte inoltrata. Misurazioni che diventano numeri a riempire ogni singola casella dei fogli di degenza. E qui il tourbillon delle “provenienze” impone discrete conoscenze geografiche, per non fare brutte figure: ragazze e ragazzi rumeni, albanesi, ucraini (dall’ottimo italiano) oltre a pugliesi, campani, siciliani. Tutti insieme, appassionatamente.







