
Non è un Mondiale come gli altri. Perché il Brasile non è un paese come gli altri. È colore, musica, saudade, samba e futebol. Favelas e spiagge favolose, Carnevale, tentazioni, inquietudini. E fino a qui siamo nel campo dei più abusati stereotipi, dei racconti improvvisati e folcloristici, degli slogan vacanzieri vincenti.
Si sente parlare molto dei favolosi must brasiliani, e il brusio aumenta esponenzialmente nei mesi che precedono la più attesa manifestazione sportiva di tutti i tempi. Ma il Brasile è ben diverso da tutti gli altri luoghi del mondo e dell’immaginario, perché coltiva un germe prezioso, incommensurabile, fecondo e segreto. Un seme che salverà il mondo, anzi, che ha già salvato il mondo, e da tempo immemore. Si chiama meticciato questo bene, questa speranza, questa àncora che pare esile e che invece è solidissima, perché fatta di sangue, di pelle e di anima.
Ecco la carta vincente per abbattere l’indifferenza delle grandi potenze occidentali, quello snobismo che molto spesso sfocia in vere e proprie forme di razzismo. Così, il Brasile che vive col fiato in gola un anno infinito – e nel 2016 ci saranno le Olimpiadi di Rio de Janeiro a rinnovare il brivido – in realtà non presenta al mondo semplicemente la propria tecnologia, la propria voglia di fare ed essere, la propria crescita economica – nonostante gli inevitabili problemi.
Non presenta solo l’ascesa sociale delle classi più povere e la comparsa di queste come ‘soggetto pensante’ (e protestante); non ostenta nemmeno i suoi stadi poderosi, le sue infrastrutture ultramoderne, le bellezze naturali che sempre ci sono state e che l’hanno fatto definire, e a ragione, “il paese meraviglioso”. No, il Brasile mostra molto di più: il sorriso del suo popolo mulatto, cafuso, euro-africano, caffelatte, scurinho, moreno, dourado: le movenze inimitabili da sfoggiare nelle peladas, i campetti spelacchiati, nelle piazze di Bahia a far capoeira, nei circoli di samba a danzare.
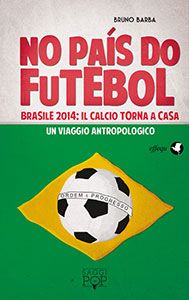
A proposito, quanta enfasi c’è sulla ‘naturalità’ di certe espressioni, che sono in realtà profondamente culturali: gli afro-brasiliani non hanno il ritmo nel sangue, l’hanno piuttosto appreso cantando e ballando per i loro dèi, mentre imparavano a schivare le frustate dei padroni, laggiù nella profonda piantagione, dove tutto era cominciato.
Ancora, il Brasile mostra il proprio jeitinho, quella capacità di aggirare gli ostacoli, di farsi voler bene anche quando si è in difetto, di ingannare, o forse di ottenere quel che si vuole. Come fa il malandro cantato dai samba: l’uomo eternamente immaturo che vive di espedienti, che ruba ai ricchi, ma che possiede un cuore nobile e in fondo sa commuovere; come la puttana, nobilitata dalla letteratura di Jorge Amado – le Teresa Batista, le Tieta e, perché no, le stesse Dona Flor e Gabriela – la garota che si dà per generosità, per altruismo più che per vil denaro: vive per l’eros, per l’amore, per la bontà, per il cuore, per salvare uomini, vite, ideali, persino paradisi naturali (rileggetevi Vita e miracoli di Tieta d’Agreste). Trasfigurazioni, queste, ovviamente romanzate, caricaturali, esagerate, ma che spiegano l’essenza di un popolo meglio di tanti saggi sociologici.
Il Brasile è un bacino sconfinato di materie prime che si unisce a rarissimi talenti: gastronomico, poetico, immaginifico, performativo. Se il Brasile vive la sua epoca liberista e privatizzatrice, è pur vero che gli investimenti a favore del popolo sono stati, in questi ultimi lustri, massicci come non mai. Aiuto allo sport di base, risorse all’educazione, all’università e alla ricerca, aumento generale dei salari, ‘normalizzazione’ delle pericolose e fino a qualche tempo fa inaccessibili favelas. Di fatto, la vera ricchezza del Brasile è il suo popolo. Nonostante quella maliziosa parabola che si racconta e che come sbarcherete a Rio, San Paolo, o Bahia, ascolterete.

La storia recita: “Dio crea una terra che non avrà terremoti, inondazioni e altre catastrofi naturali [secche devastanti sì, ma nessuno è perfetto, nemmeno i narratori delle storie]. Un luogo paradisiaco e lussureggiante, ricco di acqua, di sole, di bellezze e ricchezze naturali. L’angelo che accompagna il Signore, si interroga sul perché di un privilegio tanto ostentato e sfrontato. «Non hai visto però» dice Dio, «che razza di popolo ci metterò»”.
I brasiliani amano raccontare questa storia perché sanno, sentono davvero, di essere un popolo comunque diverso. Adorano, per certi versi, l’understatement, pronti a ribaltarlo in orgoglio. Orgoglio meticcio, appunto, che si oppone a un dispositivo malato secondo il quale il popolo stesso è insieme “ricetta di felicità” e “disastro senza rimedio”.
Se vinciamo, dicono i brasiliani, vinciamo perché siamo bambini e cioè audaci, creativi, intrepidi, originali; se perdiamo… è perché siamo bambini, in quanto irresponsabili, indisciplinati, indolenti, senza carattere. Questa sindrome si chiama paradoxo do moleque, il “paradosso del bambino”, e insieme ad altri complessi di inferiorità o spregiudicatezza condiziona i comportamenti dei brasiliani, persino in campo calcistico.
Tra informalità e impunità, tra superbia e umiltà eccessiva: così vive il brasiliano. Oggi il paese sta conoscendo, nella maniera originale e peculiare che gli è congeniale, la modernità, il progresso, la ricchezza un po’ cafona, consumistica e scriteriata. Ma è nelle partite di calcio, sotto l’abbagliante luce dei riflettori che tutto il paese si mostra per quello che è, e più orgogliosamente che mai: il calcio è un “fatto sociale totale”, nel senso che, a una lettura attenta e profonda, mostra le sue innumerevoli concatenazioni con l’economia, la storia, l’educazione, la cultura tutta di un popolo. Le partite perciò – e in un Campionato del Mondo più che mai – significano molto altro, certo molto più di un risultato numerico, un vincitore e uno sconfitto.
(04/07/2014)







